
Potrebbe essere un buon titolo per un buon libro, interessante captatio benevolentiae del lettore. Invece stai leggendo degli appunti sulle prime pagine di un romanzo finalista al premio Strega 2020. Potrebbe essere una mia stravaganza quella di parlare di ciò che non conosco a fondo, eppure sin dalle prime pagine è possibile indovinare il contenuto di un intero volume. E dopotutto le introduzioni e gli incipit sono fatti anche per questo.
Prima pagina: il luogo geografico dell’ambientazione citato nel primo rigo. È Napoli. Di questa città tutti sanno fin troppe cose. Sia chi abbia letto la Ortese oppure abbia visto un film sulla camorra. L’autrice scrive in prima persona, e afferma che qualcosa le grava addosso con riferimento indiretto alla città, ma più letteralmente alla vista di un palazzaccio al cui piano inferiore si trova l’obitorio (morgue) dell’ospedale. Poi ci viene descritto un ricordo: la protagonista è già stata lì tre anni prima per riconoscere il corpo del marito. Quel giorno era arrivata ultima in ospedale, le sorelle del marito invece erano in prima fila. Arrivata ultima perché non era stato possibile rintracciarla. L’hanno chiamata ma lei afferma che non rispondevo, come non risponderó alla maggior parte delle chiamate fondamentali all’esistenza.
E aggiunge, con enfasi: Perché insegno nel carcere minorile di Nisida e il mio cellulare squilla nella cassetta di sicurezza all’ingresso, dove il regolamento vuole che stia.
Di questo romanzo non so nulla se non ciò che sto leggendo ora e appunto in questa pagina, pur riconoscendo che potrei incorrere ad errori di interpretazione. Credo che emergano chiaramente i temi della storia: Napoli (non folkloristica ma plumbea, secondo una tradizione letteraria firmata già da Bernari nel 1934), la morte violenta del marito, le sorelle del marito (quelle cesse delle mie cognate), l’insegnamento in un carcere minorile.
Nuovo capoverso. La donna ha trascorso una notte insonne, esce e va in tribunale, lunga descrizione del luogo. Quì rivede Almarina, emergono ricordi. Qui termina il prologo, nove pagine formato e-book. Perfetto. Di Almarina, che suppongo sarà la vera protagonista della storia, non so ancora nulla. Lei ha sorriso alla professoressa, come l’ha notata nell’aula del tribunale, e possiede la luce del futuro negli occhi. L’incipit del primo capitolo è un classico: “Mi chiamo Elisabetta Maiorano…”, il lettore intuisce che la vita di Elisabetta Maiorano s’intreccerà con quella della sua studentessa detenuta (?) Almarina, all’interno di una relazione non solo educativa o scolastica. E se Elisabetta è una donna in crisi, Almarina possiede la forza della giovinezza, o ben altro.
Una nota caratteriale di Elisabetta: definisce subito i perché delle cose. E questo, più che un aspetto psicologico o cognitivo, sembra essere una caratteristica dello stile della narrazione.
Faccio un esempio di ciò che io chiamerei la pillola del giudicare.
Pag 2: “non era un ospedale qualunque, non lo fu più dopo che ci avevo trovato mio marito, morto…”, il periodo termina con una similitudine che alleggerisce l’affermazione , “il viso come se ci avessero passato sopra del talco”.
“Le sue sorelle, decise a detenere da lì in avanti il primato del dolore, così come in passato, per cose futili, ne avevano detenuto il monopolio”
Pag 3 “… non risponderó alla maggior parte delle chiamate fondamentali all’esistenza. Perché insegno nel carcere minorile di Nisida, e il mio cellulare squilla nella cassetta di sicurezza…”
“Ognuno di noi stava dove doveva stare …”
“Napoli è una città che ci sa fare con la morte…”
Pag. 4 “ le donne si vestono per celebrare”.
Pag. 8 “Almarina non aveva ricordi così “
E così via: giudizi, certezze, fino alla sentenza, quindi il parlare conciso ed efficace (l’apoftegma, credo si dica in retorica).
In attesa di leggere per intero il romanzo, mi chiedo come sia possibile una scrittura in cui, pur eliminando il punto di vista onnisciente della terza persona narrante, questo non ritorni così forte dentro una prima persona. E quindi vorrei che in questo romanzo si dimostrasse, contro le certezze e i modi indicativi del pensiero, che Napoli è una città che non ci sa fare con la morte; che ognuno sta dove non dovrebbe stare; che le donne non si vestono per celebrare; che Almarina ha ricordi come quelli della Maiorano (Maiorino forse era una professoressa tanto amata da un professore in un film…); che la Maiorano risponde alle chiamate fondamentali dell’esistenza; che le sorelle del marito non vogliono detenere il primato del dolore. E nel capovolgere il punto di vista, non si usi la figura retorica dell’apoftegma, ma la pillola del giudicare venga preparata dal lettore stesso, come quando un tempo il farmacista preparava la dose curativa nel retro della bottega.



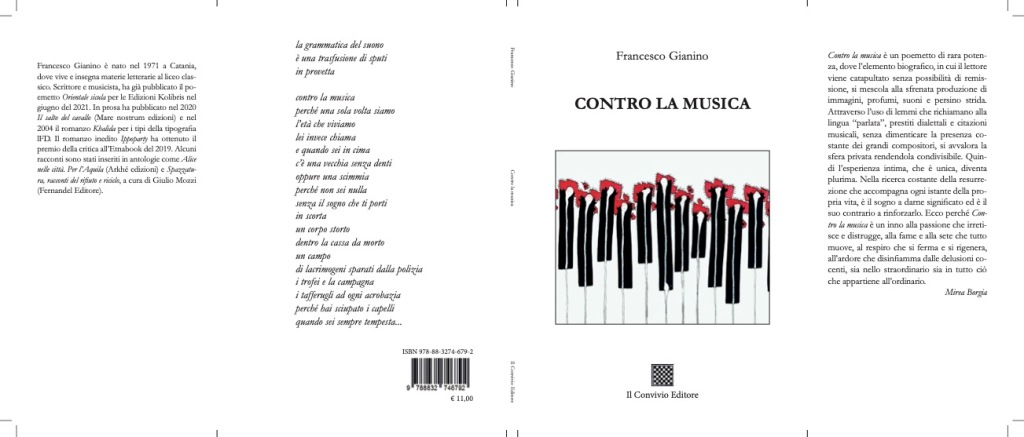

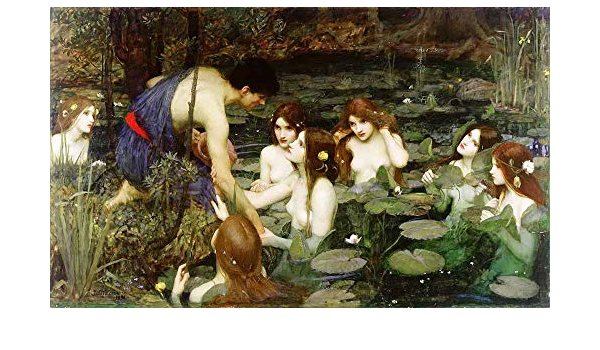
Lascia un commento