
Intervista all’autore sull’Estroverso di Grazia Calanna

Se c’è una ricerca, quando in prefazione si scomodano i presocratici e Ligeti, questa è rivolta ad una metafisica. Prima della voce, prima del ripetersi di qualunque fenomeno: il mare, il fuoco, l’acqua. Prima dell’ombra la luce. Ma tutto scorre e nulla è. Il sentimento equivalente è già un classico della filosofia greca e della fenomenologia. Archiviato dunque il supposto concettuale, è possibile cavare senso al solfeggio di fonemi a cui la poetessa affida la sintassi – l’elegante susseguirsi di misure ritmiche. L’attacco è il tema, l’impianto armonico da cui scheggiano i suoni parola. La voce non è monodica: c’è una posizione dell’io e c’è una realtà fenomenica per cui la parola ridisegna i confini: stare dentro e guardare da fuori. Almeno canone, a cui si aggiunge una terza voce, gli altri.
Ma dal tutto, da cui né storie né città si riflettono, galleggiano stupefazioni e rassegnazioni nel mare della natura.
“il carattere aggressivo per le scosse / continue le eruzioni sputata dritta / dritta dal camino centrale un delta / rovesciato senza acqua o troppa? / fiore rosso e tutti pallidi assorti / nell’indifferenza di fronte al sonno / come si dispone il buio in cielo è / una imposizione di tenerezza“
Il participio come nelle lingue antiche allunga il dettato, e l’attacco iniziale sciama, omette il predicato verbale fino alla cadenza sentenza: il buio è una imposizione.
Le sentenze ci sono. Un dire come è e cosa è, nonostante le premesse e la lontananza abissale tra voce e voce natale, tra dire ed emissione di fiato.
“Teniamoci leggeri teniamoci / al tuo capo santo rotoliamoci / la risposta è nessuna domanda: colonizzare la lingua devastarla /andare a sopravvivere su un altro / pianeta natale e devastarlo / e sciamare via e via così”
Ma anche esortazione, definizione, perdizione salvazione accalorata. Poesia che è gestualità di litania, implorazione, allocuzione eccetera, tutto quanto possa esserci di religioso verso un’entità, una oltre – natura definitiva, da cui si fiorisce o in cui marciamo. Poesia performativa che non sta più nella carta. È voce. Un solfeggio o salmodiare, sintassi ritmica procedendo per cumulo o sovrapposizioni. Il movimento attacca da un’inerte osservazione – il fenomeno – e sfora la comunicazione, s’impunta sullo scarto tra significato e significante, i gradienti dell’imbarazzo. Nulla è, tutto scorre. Posizione razionale nell’edificare l’architettura, ma istintiva nel dare voce all’insofferente nulla di cui si toccano fantasmi. La scrittura è moto – agogica – che cuce il prodigio detto male.
È anche verosimile che provare l’insignificanza col significante sarebbe un gesto da musicisti puri e convinti, oppure poeti arrabbiati per l’inerte spinta, spinta silenziosa inerte morta, delle parole. Le parole non sono tasti che suonano. Stanno ferme, non reagiscono. Le parole morte sono già sulla carta non pentagrammata appena dopo pronunciate in stato di panico abbandono. E questo oltre umano allora, così facilmente suggerito nell’illusione della natura sonora della musica, non c’è mai stato nella parola. Il morto sepolto – il porto sepolto – e dissepolto, marcio. Il biancomangiare nella clausura di mandorle è beatitudine da giuda. Nulla è, nulla si ripete, tutto è adesso, era adesso, già copia ricopiata. Il vizio intellettuale dei performer, la sindrome da Sergiu Celebidache che negava alla ripetizione registrazione la propria arte, quando Glenn Gould, viceversa, negava perfezione all’invasamento al gesto hic et nunc delle frecce di Apollo.
“la sbocciatura tra pachino e peloro / non contempla ipotesi evolutive / non è neppure una sottovariante / e se ne frega dell’impossibile / puoi ripetere? è il primo passo / falso verso l’eternità”
Ben strano – oggi non più – modo di fare poesia negando allo strumento – la parola – significato. Se l’operazione è condotta con arte, l’arte del metro e della tessitura sonora, il progetto concettuale suggerisce quanto meno un interrogativo: perché parlare di ciò di cui non si può parlare? Al silenzio è confinata l’epifania, anche se di essa rimangono i segni del tempo, le schegge di selce, i falsi paradiso del gusto, le visioni che non afferrano. La vita – la sua espressione – sciama a perdersi. La poesia, liberatasi da un io autobiografico vive nel suo pre-significato, come evocazione e negazione: quindi come momento performativo? La poesia si fa discorso musicale la cui semantica è l’impossibile significato. Cioè frustrazione da pentagramma, le cui note non significano nulla se non il loro ri-suonare nell’ascolto.
(Giulio Traversi)

Variazioni sul tema della “perdita”
di Giulio Traversi
San Lorenzo, io lo so perché tanto / di stelle per l’aria tranquilla /arde e cade, perché sì gran pianto /nel concavo cielo sfavilla.
Pubblicata da Giovanni Pascoli nel 1896 sulla rivista Marzocco, la poesia X Agosto inizia col pianto più famoso della letteratura italiana. Cadono le stelle, il cielo piange l’ingiustizia degli umani. Il cielo cade e inonda la notte di quest’atomo opaco del Male.
Il tema della caduta emerge dal mare delle perdite. La mancanza di un bene posseduto o solo bramato brilla la scintilla della poesia. Senza perdita non vi sarebbe gesto poetico.
L’amore innalza. L’assenza dell’amore fa cadere i corpi: all’illusione la delusione. Amelia Rosselli in Variazioni belliche del 1960 scrive:
(altro…)
di Giulio Traversi
Il poeta mette in guardia l’uomo: i mister, i master, i maestri sono ovunque a impartire una lezione di vita sociale. Ludwig ebbe la forza d’animo di fottersene radicalmente. Con stetoscopio sulla cassa auscultava i battiti azzurri sulla corda di rame, ma conosceva la sintassi del suono meglio di quanto un rabbino conosca il Talmud. Il mister è un corvo, solitamente le vene emergono in risalto, mette a bollire fino all’esasperazione il corpo dell’allievo, finché, tolta la curiosità di pronunciare la sentenza – sì, il giovane è dotato, oppure: non ne mangia – riconsegna all’inutile fiera del buon senso civile il desiderio: il master scarta caramelle. La cinghia di trasmissione, tra cielo e terra, si spezza, si spezzerà: si celebrano ricordi malsani ad ogni compleanno, oscillando il turibolo del destino. Ho studiato musica, ripete l’amica quarantenne, poi ho abbandonato. La fantasia partorisce possibili stami, una specie di vanto del fallimento, un ripiegamento nel sogno del sogno tra i sogni. Lo stesso capitava giocando a pallone: la combriccola faceva la squadra, fuori dal cerchio magico si era niente, in panchina, incompresi. La guerra contro le istituzioni – gli istituti consolidati da una sana vitalità e regolare minzione mattutina – è cominciata a scuola, in Istituti liceali del perbenismo. Lì la saggia misantropia del cattolicesimo ortodosso ha sferzato al corpo un definitivo veto: si educava alla missione sovra individuale.
(altro…)
La poesia non ha bisogno di musica, immagini e invenzioni armoniche: canta senza accompagnamento perché alla parola è affidato un percorso stretto, arrabbiato, stupefatto, passionale, insanabilmente malinconico, aggressivo e carnivoro. Offro all’udito non vellutate d’archi, ma significanti intersecati conditi sbollentiti e infiammati dalla visione: il sistema modale della mia povera, scarna e comunissima esistenza terrena. Lode alla semantica e alla cadenza nominale: parole dentro parole frullate dall’ingerenza di una incerta memoria. La vocazione, il talento, la rivelazione, la maestranza, l’amore, la carne, i desideri, la menzogna e l’identità. Sono queste le tematiche che luccicano tra rime e autobiologia. Campeggia l’ombra di Ludwig, seduto in un pub, l’orecchio appiccicato al woofer dell’altoparlante, quando beve un gin tonic alla menta in compagnia di una giovane ammiratrice. Solo per questa assurda barzelletta – un musicista sordo totale che impartisce lezioni di musica – ci sarebbe da invocare perdono per le tante menzogne umane, e lode per le infinite vie del Signore.
Sono versi collocati in una narrazione lunga, anche piuttosto personale. racconto le mie lezioni di musica, il mio pianoforte, la vita in condominio, le partite a calcio, la movida catanese, i cavalli al barbecù, la vita di città, i miei desideri. ma tutto questo, che è mio, è girato come la frittata in padella, perché non si bruci e questo mio e anche un ‘questo nostro o vostro’: il linguaggio poetico vorrebbe trasfigurare il privato e il meschinamente proprio, in esperienza comune. Ci provo, almeno. e quindi la poesia diventa una finestra da cui osservare l’autore ma, perfidamente, anche il lettore.
Ogni grande amore si trascina un certo odio. nel poemetto il pronome ‘io’ è piuttosto scoperto, anche se, riflettevo, non è mai quello che sembra. i primi versi del libro dichiarano una identità: eppure è una identità quanto meno triplice. C’è l’io che si guarda allo specchio, poi l’immagine allo specchio che è rivelatrice; poi ancora la dissimulazione di una vocazione, e ancora, quell’io che racconta l’imbroglio del disordine e della coscienza. Siamo almeno in quattro, e poi, infine in cinque, con me che commento!
Ogni rivelazione (folgore) sul proprio conto riporta una cifra a credito. Si paga subito oppure la cifra sarà salata, si preferisce dilazionare. Si ripone il conto nel cassetto, e si continua. Il creditore busserà alla porta, prima o poi. Chi era il nemico, che sembrava condurre verso la via torta e storta della povertà, è invece il proprio destino o carattere. Si pone quindi il problema di come fare, della propria rivelazione storta e infame, strumento di gloria e riconoscimento, integrazione. Il povero cavallo in bocca agli avventori; lo studente sognatore malmenato sulla via della scienza dal maestro. Un pianoforte che dovrebbe alitare allori, e non meccaniche aderenze.

di Ilaria Graziano
Il breve romanzo La paga del sabato è stato scritto dall’autore piemontese Beppe Fenoglio, ex partigiano durante la seconda guerra mondiale. È un’opera postuma, difatti venne pubblicata da Maria Corti (di cui troviamo la nota) la quale ha ritrovato il manoscritto nel 1969. L’edizione del 1978 si sviluppa in 139 pagine divise in nove capitoli brevi e scorrevoli. Il linguaggio è semplice, schietto, e contribuisce a rendere scorrevole la lettura.
Tutta la trama del romanzo gira attorno a un evento chiave: il ritorno di un soldato (un partigiano per l’esattezza) alla vita monotona, alla “normale” quotidianità, e il tema principale è proprio la difficoltà di adattarsi alla normalità dopo aver vissuto così fortemente durante la guerra. Il romanzo ha qualcosina di autobiografico, difatti l’autore prende spunto dal proprio vissuto. Il protagonista del racconto è Ettore giovane partigiano che si rifiuta di dimenticare la sua esperienza in guerra e quindi non vuole abbandonarsi alla routine di un lavoro dipendente.
(altro…)
Falò è l’ultima parola che conclude l’ultimo romanzo di Cesare Pavese. La frase per l’esattezza è la seguente: L’altro anno c’era ancora il segno, come il letto di un falò. Il rogo finale non è propiziatorio, parte di uno scaramantico rito di purificazione e fertilità contadina, bensì è utile per bruciare il corpo di Santina, accusata di essere una spia fascista. Il partigiano Baracca legge l’imputazione d’accusa e la sentenza finale. La ragazza seduta ascolta. Poi è condotta fuori, cerca di scappare, ma è colta da una scarica di mitra. Il corpo viene bruciato. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi. Sarmenti e benzina, poi un gran falò.
(altro…)
Nel primo capitolo de Luna e i faló Cesare Pavese s’inventa un paragone interessante. Il paese dell’infanzia, dopo una lunga assenza, mi faceva l’effetto di quelle stanze di città dove si affitta, si vive un giorno o degli anni, e poi quando si trasloca restano gusci vuoti, disponibili, morti. Il protagonista di nome Anguilla è uno sradicato. Nella vita è stato un po’ qui, un po’ lì, ha cambiato i luoghi dell’esistenza – Genova, poi in America – e non ha partecipato al cambiamento dei luoghi: dopo tanto tempo ritorna in paese e lo trova uguale nelle forme, ma cambiato nel sangue che vi circola.
La lingua di questo Pavese ha una cura al cantabile, mi sembra un tono elegiaco (Così mi misi per il prato e costeggiai la vigna, che tra i filari adesso era a stoppia di grano, cotta dal sole), che mescola il letterario a espressioni che non saprei come definire – più sbrigative, ad imitazione del parlato – rimescolando moduli veristi. Un effetto di spigoli e piallature.
(altro…)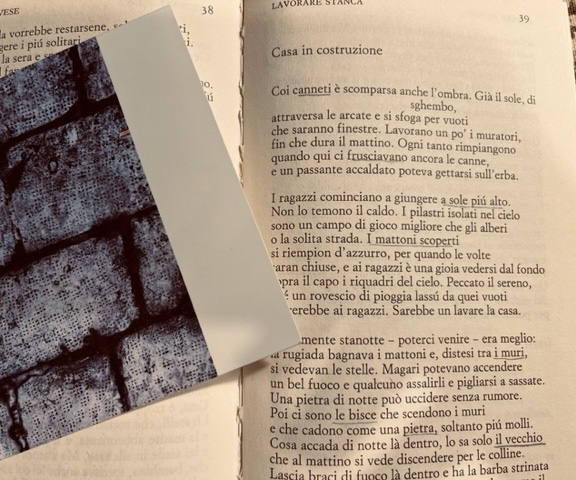
In Lavorare stanca leggo una poesia dal titolo Casa in costruzione. In Pavese sappiamo, bene o male, che le poesie, oltre ad avere uno slancio lirico, vivono di storie minime – cose che succedono, personaggi che parlano e agiscono. Così, nella poesia Casa in costruzione, si parla (se le poesie raccontano e comunicano qualcosa di preciso non perdono in dignità: se non sono pure e non imitano la musica, perseguono altri scopi. Il poeta Pavese scrivendo questi versi nel 1933 – in pieno ermetismo italiano – è un poeta quanto meno stonato. Eppure anche il Montale della Bufera racconterebbe segretamente storie di cui fa emergere creste, comignoli, cime aguzze…), in quella poesia si racconta di alcuni ragazzi che salgono sopra lo scheletro di una casa in costruzione, i pilastri sono a vista, non c’è tetto, i mattoni scoperti, le finestre vuote; i ragazzi stanno lì a guardare il cielo, salgono e scendono sui ponti, lanciano pietre, e non si capisce che altro facciano. Poi c’è un vecchio che sembra trascorra la notte al riparo dei mattoni che al caldo scottano. Dorme lì come fanno i barboni: corre i suoi rischi e s’accende di notte un fuoco.
Emerge nel testo un contrasto tra la vitalità dei ragazzi e la caparbia malmessa del vecchio. Ma quel vecchio non ha più una casa e si muove a fatica, è il commento del poeta che, in stile verista, dice lui ciò che pensa la gente che passando di là osserva i resti del fuoco e il vecchio a cui Certamente qualcosa gli accade là dentro, perché ancora al mattino borbotta tra sé.
(altro…)